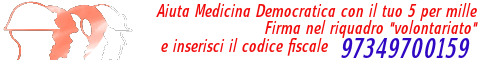Intervento a cura del Centro Studi Carla Grazioli per l’VIII convegno nazionale di Medicina Democratica del 19-21 Novembre 2015.
Intervento a cura del Centro Studi Carla Grazioli per l’VIII convegno nazionale di Medicina Democratica del 19-21 Novembre 2015.
Sezione: Salute Mentale e OPG
La carcerizzazione delle politiche sociali e il ruolo dei saperi psy: un programma di ricerca sulla contenzione
Abstract. La contenzione ha un ruolo ancora significativo in molti contesti sociali e sanitari. Questo contributo sociologico ne propone un’analisi rivolta ad indagarne il senso nell’economia complessiva dei servizi di salute mentale al fine di sottolinearne gli effetti di riproduzione sui contenuti e le forme dei saperi “psy”, oggi diffusi in una molteplicità di contesti sanitari, sociali e assistenziali. Per svolgere questa indagine è utile tornare a promuovere un’impostazione epidemiologico-critica, orientata a cogliere l’influenza che la strutturazione istituzionale delle risposte assistenziali esercita sulla definizione dei bisogni di salute. Per considerare l’ampiezza del problema è utile infine allargare lo sguardo alle nuove funzioni di invalidazione assunte dai saperi “psy” nelle politiche sociali neoliberali. Le modalità di segregazione e gestione della devianza non hanno più bisogno del grande manicomio ma si appoggiano a servizi sociali territoriali, centri residenziali di trattamento, comunità terapeutiche e centri per l’impiego. Sono istituzioni di formato ridotto, più “leggere”, che non devono segregare a vita ma riformulare traiettorie di vita per tempi ridotti, in un contesto di “rotazione” e “distribuzione” delle tradizionali funzioni dell’ospedale psichiatrico. Dagli sportelli per l’assistenza sociale alle comunità terapeutiche intensive, si tratta di una gamma di mini contesti istituzionali in cui si riproduce la funzione di controllare i soggetti che non trovano posto nell’ordine sociale e trattare i loro comportamenti, con una rinnovata enfasi sulla territorialità, sulla responsabilità individuale e sull’appropriatezza del trattamento. Per cogliere i luoghi e le dinamiche di questa diffusione dell’invalidazione tecnica, e della contenzione come sua forma radicale, bisogna analizzare complessivamente lo shifting in corso nelle politiche sociali e cogliere al suo interno il ruolo assunto dai saperi e dalle pratiche “psy”.
Testo
Fornire una rappresentazione precisa della diffusione della contenzione nei servizi psichiatrici e negli altri contesti di “presa in carico” assistenziale, sociale o sanitaria non è affatto facile: ad oggi non esiste alcun programma scientifico rivolto alla comprensione del fenomeno e alla sua rilevazione sul territorio nazionale. L’obiettivo di questo contributo è quello di mostrare come dovrebbe essere e che obiettivi dovrebbe porsi tale programma di ricerca. In primo luogo esso dovrebbe riguardare una molteplicità di contesti istituzionali. Il reparto psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale generale, residuo dell’antica istituzione totale, viene infatti considerato il luogo demandato alla contenzione psichiatrica, ma di fatto non costituisce l’unico contesto di gestione “contenitiva” del disagio sociale, delle contraddizioni esistenziali e dei comportamenti conflittuali. Il “repartino”, come ancora viene chiamato da molti operatori e utenti psichiatrici, mantiene certo la sua importanza poiché dentro di esso quotidianamente si rinnova il nucleo centrale del sapere e della prassi psichiatrica, tuttavia esso si accompagna oggi ad un folto gruppo di contesti genericamente restrittivi come i reparti carcerari, i centri di identificazione ed espulsione, i centri d’accoglienza per i richiedenti asilo, le strutture protette per minori, le case-famiglia per madri sole, gli ospedali psichiatrici giudiziari, le case di riposo per anziani, le case di cura neuropsichiatriche, le strutture protette per senza fissa dimora, le residenze socioassistenziali e sanitarie a trattamento prolungato e molteplici altri reparti ospedalieri come pronto soccorso, geriatria e chirurgia.
Capire il fenomeno “contenzione” significa indagare i contesti istituzionali in cui questa prassi si esercita, mettendo in luce che una certa organizzazione istituzionale conferisce al vissuto di disagio la forma che gli è più congeniale. Secondo l’approccio epidemiologico-sociale, infatti, studiare la diffusione di una certa condizione “clinica” è possibile solo sulla base di uno studio dell’organizzazione dei servizi. È infatti la forma istituzionale assunta dai servizi a plasmare e modellare a propria immagine ciò che possiamo solo sbrigativamente etichettare come “malattia”. Una volta chiarito il nodo che stringe insieme la psichiatria e la contenzione, è utile gettare uno sguardo alla dinamica di “diffusione” dei saperi e delle pratiche psichiatriche nel campo vasto della “presa in carico”. Infatti, la permanenza della contenzione nei reparti ospedalieri consente che tutta la pratica e il sapere psichiatrico possano fondarsi sulla strutturale riduzione dell’uomo a cosa: ogni snodo della presa in carico “diffusa sul territorio” tiene dentro di sé la possibilità che ciò accada, per quanto “in ultima istanza”. Come suggerisce Robert Castel ne Il mito della deistituzionalizzazione, «dal tempo in cui prigione e manicomio si spartivano il dominio esclusivo dell’internamento, la rete delle istituzioni segregative si è allargata e differenziata e il passaggio dell’internamento si è complicato a tal punto che risulta difficile tracciarne la mappa esatta». Le modalità di segregazione e gestione della devianza non hanno più bisogno del grande manicomio ma si appoggiano a servizi sociali territoriali, centri residenziali di trattamento, comunità terapeutiche e centri per l’impiego. Sono istituzioni di formato ridotto, più “leggere”, che non devono segregare a vita ma riformulare traiettorie di vita per tempi ridotti, in un contesto di “rotazione” e “distribuzione” delle tradizionali funzioni dell’ospedale psichiatrico. Dagli sportelli per l’assistenza sociale alle comunità terapeutiche intensive, si tratta di una gamma di mini contesti istituzionali in cui si riproduce la funzione di controllare i soggetti che non trovano posto nell’ordine sociale e trattare i loro comportamenti, con una rinnovata enfasi sulla territorialità, sulla responsabilità individuale e sull’appropriatezza del trattamento. Per cogliere i luoghi e le dinamiche di questa diffusione dell’invalidazione tecnica, e della contenzione come sua forma radicale, bisogna analizzare complessivamente lo shifting in corso nelle politiche sociali e cogliere al suo interno il ruolo assunto dai saperi e dalle pratiche “psy”.
Con il concetto di «detenzione sociale» si indica «l’incarcerazione di persone che vivono in uno stato di svantaggio, disagio o marginalità e per le quali, più che una risposta penale o carceraria, sarebbero opportune politiche di prevenzione e sociali appropriate», come sostiene Alessandro Margara1. «Detenuti sociali», in questo senso, sono i tossicodipendenti, gli immigrati e tutti quei soggetti non integrati come senza dimora, sofferenti psichici, ecc. Ciò che li accomuna è la precarietà della loro condizione, legami sociali frammentati o inesistenti, l’accumularsi di fatiche cresciute negli anni2. Le ricerche sul sovraffollamento carcerario mostrano l’ampiezza e la gravità di questo fenomeno. Con il termine di carcerizzazione delle politiche sociali vogliamo indicare lo slittamento di una serie crescente di problemi dall’ambito delle politiche sociali a quello della detenzione. Questo processo non riguarda solo gli equilibri tra i due vasi comunicanti dell’assistenza sociale e della gestione penale, ma comporta una mutazione interna delle politiche sociali (e sanitarie), che progressivamente si spingono verso dinamiche repressive, espulsive e punitive.
La carcerizzazione delle politiche sociali è la diretta conseguenza della forma assunta dagli attuali sistemi di welfare community, fondati sull’idea che la presa in carico dei rischi sociali deve essere un ambito di investimento più che di assistenza, e che la comunità, intesa come sistema di relazioni tra privati, deve proporre risposte virtuose (cioè valorizzabili) ai problemi piuttosto che promuoverne una riformulazione politica oppure richiederne una soluzione da parte dello Stato. Le forze materiali che promuovono questa trasformazione sono la riforma in senso aziendalista delle pubbliche amministrazioni e la penetrazione dei soggetti imprenditoriali nell’erogazione di servizi. Come è noto le politiche neoliberiste riducono lo Stato a regolatore del gioco di mercato tra liberi contraenti, suffragate dalla convinzione che sottrarre ambiti di mercato all’intervento pubblico e aprirli al libero investimento di capitali costituisca uno stimolo per la crescita. Il “mercato sociale”, inteso come il mercato di beni e servizi che hanno la socialità come prodotto, è uno dei nuovi campi di investimento imprenditoriale: ciò che prima era “questione sociale” oggi è soprattutto materia che chiama in causa il lavoro non pagato di cura familiare e la concorrenza tra i privati. Scompare quella che era stata definita “proprietà pubblica”, quell’ambito di redistribuzione della ricchezza che aveva costituito il fondamento socialdemocratico dei diritti di cittadinanza3. Le politiche pubbliche attivano in compenso la retorica sulla solidarietà, sulla sussidiarietà e sulla partecipazione, per evocare il nuovo ruolo “attivo” che i cittadini sono chiamati ad assumere nella realizzazione della “sicurezza e coesione sociale”. Il tutto favorito da un clima culturale che fa leva su una specifica definizione dell’insicurezza: essa non indica più incertezza economica, debolezza delle garanzie di accesso al reddito e scarsità di diritti, piuttosto l’insicurezza è declinata come desiderio di difesa poliziesca nei confronti di un potenziale soggetto criminale che attenta alla vita, alla proprietà privata e al decoro dei luoghi urbani4.
Il neo paternalismo delle politiche sociali si sviluppa quindi in conseguenza di due ordini di fattori integrati: l’articolazione del mercato (o quasi-mercato) dei servizi e lo slittamento delle politiche sociali verso modelli tendenti al workfare. Da una parte, il mercato delle prestazioni sociali (spesso regolato dai manager dei servizi sociosanitari) richiede che profili ben definiti di utenti siano assegnati a profili altrettanto ben definiti di prestazioni. Questo significa che ogni forma di “presa in carico” deve essere estremamente selettiva e tecnicamente specifica: il minore straniero non accompagnato deve essere rigidamente tenuto distinto da un giovane all’esordio psicotico, la madre sola di una minore vittima di tratta rientra in una categoria diversa rispetto ad una lavoratrice single in cerca di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro in una moderna e accogliente struttura di co-working, e così via. Ogni convenzione, ogni investimento, ogni “progetto” in cerca di appalto tematizzano una categoria ben specifica di destinatari, approntano le expertise in relazione con i loro bisogni e potenziali di sviluppo e, sulla base della raffinatezza con cui è descritto questo sistema di corrispondenze, aspirano ad ottenere un finanziamento dalla AUSL, dalla grande fondazione bancaria o dal fondo sociale europeo. Nei fatti questa impostazione produce una semplificazione della lettura dei bisogni: a un’ottica complessa e socializzata, capace di cogliere le interazioni tra contesto, soggetti e dinamiche macrosociali, si sostituisce una tendenza secondo cui a specifiche condizioni “naturali” dell’utente corrisponde una precisa modalità di presa in carico. La domanda espressa dal contesto viene analizzata in modo semplicistico o non viene analizzata affatto, se non in termini di «richiesta di espulsione»; non viene dunque colta l’interazione di processi naturali e sociali che la determina. La “condizione di disagio” deve essere oggettivata, categorizzata, incasellata: solo così il bisognoso diviene merce, valorizzabile dalle istituzioni che si occupano della sua gestione. Ad ogni etichetta diagnostica deve fare immediatamente seguito una prestazione, dotata di un certo costo, attribuita a certi specialisti. Questa connessione deve essere univoca, sancita da un gruppo di tecnici e formalizzata in un protocollo. Inevitabilmente questa moltiplicazione di “tipologie di utenti”, univocamente definiti da un bisogno specifico, produce nella pratica una quantità infinita di «utenti inadatti al progetto». In molti casi si tratta di utenti resistenti, rivendicativi, che si lamentano, la cui scarsa adesione al profilo del servizio non mancherà di essere riportata al giudice competente nella relazione dell’assistente sociale, con tanto di test psicologico attestante la tendenza oppositiva della personalità e la maggiore coincidenza del profilo con un servizio “a maggiore protezione”.
In secondo luogo le prestazioni di assistenza sociale riservate a inoccupati e disoccupati sempre di più si fondano sulla retorica dell’attivazione. In pratica attivazione significa concentrazione sull’individuo (e mai sulle macrodinamiche economiche), valorizzazione della sua responsabilità (quindi attribuzione all’utente degli eventuali fallimenti del progetto), dettagliata e continua misurazione del suo profilo psicologico, comportamentale, morale. Si tratta appunto di politiche moralistiche e paternalistiche, il cui punto centrale è l’esame della compliance dell’utente, intesa come disponibilità a modificare attivamente la propria condotta, implementare il proprio capitale umano: come se i destinatari degli interventi di assistenza sociale «fossero essi stessi responsabili della situazione in cui si trovano»5. Più della concreta condizione di bisogno in cui l’utente si trova conta mostrare il “merito” per accedere alla fruizione di benefici. Per chi non supera la «selezione dei clienti adatti alla risposta» si apre la carriera morale di successive stigmatizzazioni, attraverso la quale l’utente “difficile” viene scaricato su una serie di altre micro-istituzioni in cui sono più marcati l’etichettamento diagnostico e/o la presa in carico coercitiva.
A fare da spartiacque in queste carriere morali da portatori di bisogni è la condizione socioeconomica e il relativo potere contrattuale dei soggetti. «Gli strumenti adottati per attuare politiche indirizzate a soggetti o gruppi con immagine negativa sono generalmente più coercitivi ed autoritari di quelli rivolti ai gruppi ritenuti meritori, per i quali si adottano interventi che promuovono la capacità di autogestione, quali l’informazione e l’apprendimento, in quanto viene loro implicitamente riconosciuta una maggiore capacità di scelta autonoma. Gruppi costituiti negativamente, o percepiti come particolarmente vulnerabili o fragili (come anziani o bambini) sono costruiti nelle politiche pubbliche come se abbisognassero non solo di nuove opportunità, ma anche di un certo grado di supervisione esterna o di costrizione rispetto alle scelte personali di ciascuno»6. Come ha ben argomentato Franco Basaglia, il modello di gestione dei sistemi assistenziali determina la “condizione problematica” a propria immagine: “in epoche successive la malattia e i suoi sintomi sono sempre stati influenzati e condizionati dai nuovi orientamenti terapeutici (…), noi produciamo una sintomatologia – il modo di esprimersi della malattia – a seconda del modo col quale pensiamo di gestirla, perchè la malattia si costruisce e si esprime sempre a immagine delle misure che si adottano per affrontarla”7. Da ciò deriva che un primo passo per osservare la contenzione con approccio sociologico richiede di dedicare una specifica attenzione ai meccanismi, interni alle istituzioni, di segmentazione dei percorsi di presa in carico. Come scrive ancora Franco Basaglia nel 1975, quello che si osserva nella psichiatria delle società “post-manicomiali” è una sostanziale differenziazione degli apparati, con zone liminali tra malattia e devianza, zone di distanziamento e zone di sovrapposizione, a causa dell’allentamento (ma non affatto risoluzione) della saldatura tra malattia e controllo sociale. Il meccanismo che Basaglia illumina spietatamente è quello che conduce alla creazione di zone di “massimo” e di “minimo” investimento nella sanità. Quelle di minimo investimento riguardano le popolazioni strutturalmente espulse dalla produzione mentre quelle di massimo investimento riguardano i soggetti “integrabili” nell’ordine della produzione e del consumo. Si tratta di ambiti in cui emergono le figure di nuovi tecnici specifici, con l’apparenza della neutralità e dell’indipendenza dalle vecchie istituzioni manicomiali, ma che nei fatti agiscono come nuovi funzionari del consenso.
La moderna presa in carico dei problemi sociali nei sistemi di welfare community ricalca esattamente la descrizione di Basaglia: secondo l’ideologia che in essi domina, i bisogni rappresentano il sintomo di una scarsa attivazione di capitale umano; la loro inadeguata o mancata soddisfazione tecnica rappresenta una perdita di produttività, se non un rischio per la coesione sociale; le innumerevoli modalità di scarso o disfunzionale investimento della persona sul suo potenziale adattivo e creativo, sulla sua autonomia e imprenditorialità vanno diagnosticate e risolte tecnicamente, attraverso un intervento professionale, scientifico. Chi, rispetto a questa nuova prateria aperta all’investimento capitalista, rappresenta una resistenza, un oltraggio, un paziente intrattabile, subisce un declassamento di investimento. Il suo capitale umano verrà altrimenti valorizzato.
Robert Castel8 ha provato a inscrivere queste microdinamiche in una grande descrizione sociologica, spiegando l’ultima metamorfosi della questione sociale: cresce il gruppo dei “sovrannumerari”, strutturalmente espulsi dalle garanzie della condizione salariale, nel frattempo le politiche sociali si strutturano in modo che questi “esclusi” siano chiamati ad aderire attivamente a progetti di assistenza “tendenzialmente” impossibili, nella misura in cui richiedono l’elaborazione di un “progetto di vita” a cui non viene offerta alcuna possibilità concreta di realizzazione. Sostanzialmente si tratta di utenti “presi in carico” che, attraverso l’azione performativa delle politiche pubbliche, si vedono scaricare addosso la gran parte della responsabilità per la propria condizione. Si tratta ancora di una forma, seppur paradossale, di “inclusione”. La nuova società del capitale umano vuole essere tutto: gli inclusi sopporteranno la forma di inclusione che si meritano. Viene dunque riesumata l’antica distinzione tra «poveri abili al lavoro» (da punire se non lavorano e da assistere se si sottomettono) e handicappati, a cui l’inclusione nella cittadinanza si presenta sotto forma di un paternalismo caritatevole, ricattatorio e fortemente assoggettante.
Loic Wacquant ha raccolto alcuni esempi pratici di questa tendenza con un titolo incisivo: “punire i poveri”9. A questo processo complessivo infatti corrisponde una generale involuzione della formazione e della prassi degli operatori, che tendenzialmente si accosta al «pensiero unico securitario». Paradigmatico è il caso delle politiche penali e carcerarie, in cui si nota uno shifting di grande portata: «trent’anni fa i Parole Officers uscivano dalle scuole per assistenti sociali e studiavano i fondamenti della psicologia e della sociologia, oggi mentre i casi da seguire sono raddoppiati essi si formano nelle scuole di giustizia criminale, dove apprendono le tecniche di polizia e l’uso delle armi da fuoco. La nuova filosofia panoptica che li guida è sottolineata da questo slittamento semantico: i programmi di Parole sono stati recentemente ribattezzati “Liberazione sotto controllo e Controllo in comunità”, sotto il nuovo regime liberal-paternalista infatti l’individuo liberato con la condizionale non è tanto un ex pregiudicato restituito alla libertà quanto un quasi prigioniero in attesa di un imminente ritorno dietro le sbarre»10.
Questo scenario costituisce il nuovo campo di applicazione del sapere-potere psichiatrico. Un sapere che sempre più si presenta come “tecnico” e “umanista”, che sempre più tende a rappresentarsi ripulito da ogni parvenza di arbitraria violenza, tecnicizza le forme di presa in carico per sedersi al tavolo dove i “normali”, ma potenzialmente sovrannumerari, verranno scrutati, oggettivati, esaminati e valutati per essere assegnati al progetto di «inclusione e cittadinanza attiva» più consono alla loro capacità di autogestione. Il sapere psichiatrico implicato in questi processi è lo stesso che nell’antro dell’istituzione psichiatrica trova il suo motore immobile: l’invalidazione, la manipolazione e l’oggettivazione del soggetto, il nascondimento dei suoi bisogni restano le sue caratteristiche.
Parlare di contenzione e psichiatria significa dunque aggredire il centro del problema sociale, nel momento in cui la forma di oggettivazione psichiatrica si estende a tutta la società informando di sé ogni forma di “presa in carico della crisi”. Il modello di oggettivazione dell’uomo che la psichiatria porta in sé è un modello infatti utile in una molteplicità di situazioni istituzionali. Lo psichiatra e il suo sapere tuttora forniscono le pratiche e i discorsi che consentono di ridurre la resistenza, la ribellione, la rivolta dell’uomo a manifestazione psicopatologia, a sindrome di agitazione psico-motoria, ad agito auto o etero aggressivo. Dietro queste manifestazioni lo sguardo psichiatrico sa riconoscere la presenza possibile di un disturbo antisociale di personalità, di un quadro borderline o di un evento di perdita non correttamente elaborato in senso depressivo. La coesistenza di cura e custodia nel mandato psichiatrico continua a svolgere un’importante funzione sociale: permette di operare l’oggettivazione che in ogni contesto sociale giustifica la detenzione, la restrizione e la custodia, razionalizzando questi atti come conseguenze di caratteristiche della soggettività abnorme di colui al quale queste misure si applicano. Il lungo processo di “medicalizzazione” della psichiatria, che ha cercato di normalizzarne la pratica e di assimilarne la teoria all’asciutta oggettività delle scienze positive, non ha permesso di superare il problema della gestione dell’abnorme e dell’escluso, che ancora si manifesta nel controllo della “crisi”. Anche un’impostazione puramente medica, orientata a rafforzare la scientificità della psichiatria come disciplina della riparazione, non risolve la contraddizione di fondo poiché la stessa medicina ripropone a un livello più ampio il tema dell’esclusione, della sua gestione e della sua razionalizzazione scientifica.
Come prevedeva Basaglia, l’inserimento completo della psichiatria nella medicina non ne ha risolto le contraddizioni. La «manipolazione dei bisogni» che le istituzioni operano si mantiene viva ed operante pure in ambito sanitario. La riduzione del soggetto a cosa sotto il potere dello sguardo medico espropria il malato dalla sua esperienza, «il malato si trova a vivere la sua malattia come qualcosa di estraneo alla vita, per affrontare il quale deve affidarsi alla “scienza” diventando tutto malato. Il che gli impedisce di vivere la malattia come un’esperienza personale che non spezzi il continuum della vita e alla quale potrebbe soggettivamente partecipare con l’aiuto della scienza»11. Per una di quelle antifrasi a cui ci ha abituato l’ideologia capitalista, che ci fa considerare l’esclusione come meritocrazia e la guerra come pace, anche «la razionalizzazione della contenzione» può nascondere il vero volto di un processo sociale più minaccioso: la penetrazione subdola del sapere e della pratica psichiatrica più oggettivante in ogni ambito dove ci sarà da invalidare, escludere e razionalizzare l’esclusione con una categoria scientifica, sempre e solo a vantaggio degli interessi delle classi dominanti.
Luca Negrogno
(Sociologo, co-redattore della rivista “Quaderni di inchiesta sociale”, membro dell’Associazione “Centro studi Carla Grazioli).
PSICHIATRIA DEMOCRATICA
DOPO MONTELUPO
Oplà! Con una (speriamo) ultima giravolta – Delibera 565 del 27.4.2015 – la Regione Toscana si è rimangiata la sua delibera(380/15)di trasferimento degli internati toscani da Montelupo a Solliccianino (decisione che aveva sollevato unanimi e sdegnate critiche) individuando la REMS a vigilanza intensiva perimetrale nel Padiglione Morel di Volterra – che già ospitava un modulo residenziale per dimessi opg – e una struttura intermedia per l’Area Vasta Centro a Villa Guicciardini a Firenze.
In articulomortis(e anche un po’ oltre) la Regione è forse riuscita ad evitare il Commissariamento anche se questa eventualità, considerata l’incapacità dimostrata in questi anni a gestire il superamento dell’opg, avrebbe messo un po’ di ordine e coerenza nel sistema.
Con la individuazione delle REMS provvisorie, pur con i loro limiti – soprattutto per la dimensione assunta da quella di Volterra -si apre comunque una nuova fase in cui la Regione dovrà fare quello che non ha fatto in questi anniper realizzare concretamente il superamento dell’opg senza limitarsi ad una semplice trans-istituzionalizzazione degli internati.
Per questo ribadiamo quelle che da sempre sono state le nostre richieste e proposte.
Chiediamo pertanto che:
1. La Regione istituisca immediatamente un gruppo di lavoro dedicato – una task force– con i Responsabili dei DSM e dei SerT (molti internati hanno una doppia diagnosi) per formulare o riformulare i programmi di dimissione. Non è possibile che quasi l’80% dei presenti a Montelupo risulti non dimissibile quando la media negli altri opg oscilla tra il 10 e 20%; i “folli-rei” toscani sono forse antropologicamente diversi dagli altri?
Il gruppo di lavoro deve avere un Responsabile certo e dotato degli stessi poteri di un Commissario ad acta.
Sarebbe utile che al gruppo partecipassero rappresentanti dei servizi sociali nonchè della società civile e/o delle associazioni del territorio.
2. Per applicare correttamente la Legge 81/14 occorre un continuativo collegamento tra Magistratura e Servizi di Salute Mentale. La Regione si faccia parte diligente, così come hanno fatto altre Regioni (v. Emilia Romagna) con ottimi risultati, per istituire un Tavolo Permanente tra Magistrati e operatori dei servizi che affronti tutte le problematiche connesse all’applicazione concreta della legge con l’obbiettivo di giungere ad un Protocollo operativo sottoscritto e vincolante per tutti i soggetti interessati.
3. Le Rems siano realmente provvisorie nella prospettiva di superarle restituendo, quanti più possibile, gli ospiti a strutture di piccole dimensioni, nel loro territorio di provenienza, gestite direttamente dal DSM di competenza al di fuori di ogni logica concentrazionaria e neo-istituzionalizzante.
4. Venga perciò abbandonato il progetto di costruire ex novo una REMS definitiva impiegando diversamente il relativo finanziamento tanto nelle suddette piccole strutture quanto soprattutto nel potenziamento degli organici dei servizi di salute mentale
Arezzo/Napoli, 29.4.2015
Cesare Bondioli – Resp. Naz. Carceri e OPG Psichiatria Democratica